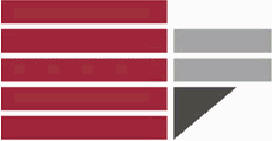Il titolo del libro “Il garibaldino di Brattirò” potrebbe trarre in inganno.
Il titolo del libro “Il garibaldino di Brattirò” potrebbe trarre in inganno.
All’ignaro lettore sembrerebbe prospettare una storia epica fatta di episodi guerreschi, avventurosi, come tutte le storie che parlano di Garibaldi e dei suoi mille.
A me pare in maniera più pertinente la storia, la saga di una comunità giunta ai nostri giorni quasi incontaminata, con una cultura che si pasce di un senso religioso di appartenenza.
Un posto, Brattirò, tra le colline, fatto di prati, vigneti, alberi, attraversato da ampie radure, con la connotazione di luogo sacro come appare agli occhi di fanciullo di Michele che si compiace della fisionomia tipica del suo paese e del suo relativo benessere.
Michele fa di Brattirò un luogo unico, una fiaba mitica, un posto che lui sa legare magicamente alla storia, alle gesta, all’evento del garibaldino Ferdinando.
Una località Brattirò che nella ricorrenza del culto dei SS. Cosma e Damiano, di importazione monastico-bizantina, è meta di un notevole concorso popolare e suscita una attrazione quasi fascinosa.
Fino a pochi anni fa la ricorrenza era una interessante vicenda folkloristica, ricca di colori e di consuetudini. Le mutate condizioni della vita moderna hanno dissolto questo patrimonio di tradizioni popolari.
Chissà…..
Con questo testo Michele ritorna ai luoghi dell’infanzia, ritorna alla memoria, dove accadono cose uniche che trascendono dal resto del mondo e l’animo di Michele diventa poeta e sognatore nel descrivere la natura e la campagna di Brattirò.
Leggere questo libro di Michele è un piacere, perché Michele ha saputo creare la giusta attesa, la giusta curiosità, colloquiando a lungo, per oltre metà dell’opera, con il suo paese, prima di raccontare della figura del suo eroe Ferdinando, con i personaggi della sua infanzia, cedendo alla descrizione, accostando sentimenti e sensazioni, talvolta con una vena sottilmente ironica compiacendosi nel ricordare i soprannomi, i mondi scomparsi.
Mi ha colpito la descrizione della donna che fa la coroncina con la tovaglia sulla testa per aiutare ad attutire le pesanti ceste. Oggi è una pratica totalmente in disuso.
Questo libro celebra anche il lavoro, come avviene in altri scritti di Michele dove l’umile, l’arreso, il vinto la fanno sempre da protagonista.
Michele, infatti, nei suoi scritti ha sempre un occhio attento e vigile per i vinti per gli arresi. Questo lavoro come i suoi precedenti (Cinanca, Peppareu Bomporti, Baraccoti e Campoti, ecc) trova la sua dignità e sicura collocazione in quello che noi letterariamente potremmo definire il “ciclo dei vinti” in una chiave tutta locale.
Il Garibaldino di Brattirò è una storia che si accomuna a tante altre che hanno segnato il mondo rurale meridionale del tempo con molti lavoratori che hanno seguito il mito di Garibaldi alla ricerca di un riscatto dalle condizioni di miseria e sottosviluppo.
Non a caso la partecipazione dei garibaldini calabresi all’impresa dei Mille è stata sempre storicamente associata al riscatto dai nefasti giorni del brigantaggio.
E qui si innesta il capolavoro diplomatico e culturale di Ferdinando all’interno della comunità massonica dalla densità più elevata rispetto al resto d’Italia, quella di Vibo Valentia e di altri centri della Provincia.
Un dato che ancora oggi non manca di sorprendere anche illustri magistrati i quali pensano di spiegare un simile primato solo attraverso il codice penale, criminalizzando tutto un movimento che merita maggiore attenzione e considerazione.
Questo perché nessuno tiene conto della storia.
Il fenomeno odierno si cala infatti sulla scia di un’antica tradizione lasciata in Calabria da numerose personalità.
Qui infatti nacquero ed operarono Antonio Jerocades (lui infatti è attribuita la istituzione della prima loggia calabrese a Tropea, Francesco De Luca (che succedette a Garibaldi nella Gran Maestranza Nazionale), Saverio Fera, Vittorio Colao, ecc.
Una regione la Calabria e la Città di Vibo Valentia di corposità massonica che il giovane ed acculturato Ferdinando, allievo di Ammirà, trova il modo di lodare di fronte al suo eroe Garibaldi e nello stesso modo esaltare i nobili ideali praticati da uomini rispettosi delle leggi della patria, osservanti dei diritti dell’uomo e del cittadino, irreprensibili nel comportamento privato e sociale.
E qui il lavoro di Michele apre un nuovo capitolo ed inconsciamente si cala nell’eterno dualismo “garibaldini o briganti”.
Chi legge questo lavoro non può ancora una volta domandarsi sulle contraddizioni che la Questione Meridionale si porta dietro nella sua ormai secolare storia, portandosi dietro tutte le peculiaretà, ed in parte devianze calabresi, che vanno dal brigantaggio all’emigrazione, alla lotta di classe, alle rivolte contadine, fino alla mafia e criminalità organizzata.
Sulla resa del Generale Ghio e dei suoi diecimila uomini, avvenuta il 30 agosto a Soveria Mannelli, su cui Michele si sofferma con dovizia di particolari ed acute intuizioni di strategia militare, in seguito all’azione diplomatica svolta da Ferdinando Bianchi ed Eugenio Tano, gli storici si sono sempre interrogati.
Possibile che una forza militare così cospicua ed armata di tutto punto si sia potuta arrendere ad un pugno di uomini, mal armato ed esausto per la lunga marcia fin lì compiuta?
L’ipotesi storica più accreditata è che il Generale Ghio si sia lasciato condizionare da notizie false opportunamente costruite e fatte circolare. Tuttavia molti sono i lati della vicenda ancora oggi rimasti all’oscuro.
In questo racconto di Michele c’è la chiave di volta di quanto è avvenuto per opera di un figlio di Brattirò che ha mostrato anche una certa intelligenza militare ed a cui arrideva una brillante carriera al servizio di Garibaldi.
Un dato è certo ed inconfutabile: la storia racconta che i mille di Calatafimi al Volturno erano cinquantamila, anche per merito dei tanti Ferdinando che erano capaci di coinvolgere non tanto uomini colti come l’elite massonica vibonese, ma anche tanti lazzaroni a diventare soldati.
La vicenda del giovane e sfortunato Ferdinando merita di essere conosciuta al grande pubblico alla stregua di altre vicende garibaldine che pure non suscitano l’emozione e la commozione per il destino amaro e crudele toccato al nostro giovane.
Il libro si caratterizza anche per la pienezza di citazioni e di principi etici, che si richiamano ad un filo conduttore non secondario della storia socialista di cui è figlio Michele, definito appunto “socialismo religioso”.
Perché la celebrazione del lavoro è una caratteristica fondamentale anche degli altri scritti di Michele.
Michele pratica la scrittura, partendo dalla sua attività artigianale, come lui stesso afferma, attraverso lo scambio di idee con i suoi avventori che sono pure suoi amici, e che contribuiscono alla copiosa raccolta di aneddoti, confidenze che arricchiscono i suoi scritti:
– Il rapporto con le comunità vicine,
– La vita del Don Girolamo borghese ma nel contempo amico dei contadini e dei nobili.
Questo testo di Michele recupera e salva parecchio della nostra memoria ed un ambiente umano e culturale in pieno dissolvimento.
Quando ho incominciato a leggere questo libro l’immaginazione mi ha portato, senza una plausibile ragione, ad immaginare Michele pronto a dipinge un quadro sorprendente di pittura napoletana dell’ottocento, come se ne vedono tanti, in molte case nobiliari della nostra zona, specie a Tropea ed a Vibo, con figure e protagonisti descritti con l’occhio incantato ed interessato del giovane Ferdinando (camice rosse, garibaldini a cavallo, ecc. all’interno di una natura con una lunga sequela di verde che lascia intravedere una realtà rustica ed umile.
In un certo senso lancia un messaggio ai tanti giovani che possono ed hanno voglia di ascoltarci: salvate la terra della nostra anima, per farla ritornare come la descriveva il De Sanctis: Una terra ricca di risorse, abitata da un popolo forte e generoso e da una intellighentia liberale ed onesta. Per De Sanctis la Calabria era “una terra di grandi speranze, perché la natura è ancora primitiva e l’uomo ancora forte”.
Facciamo in modo che possa essere ancora così.
Alfonso Del Vecchio